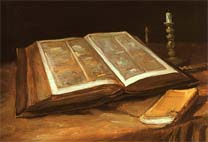Sof
2,3.3,12-13: Lascerò in mezzo a te un popolo povero e
umile
Sal 145
1 Cor 1,26-31: Dio ha scelto ciò che è debole
nel mondo
Mt 5,1-12a: Beati i poveri in spirito
Con
questo passo inizia il primo dei cinque grandi discorsi di Gesù
nel vangelo di Matteo che si prolunga fino a 7,28 e termina
con la formula "al termine Gesù…", analoga
a quella dei restanti discorsi. In questo discorso e nelle azioni
seguenti appare ripetutamente menzionata la "autorità"
di Gesù. Questo riferimento all'autorità fa intendere
questo sermone come la proclamazione della legge fondamentale
del Regno dei Celi (di Dio).
La posizione assunta "si sedette" e, soprattutto,
il luogo della proclamazione "la montagna" (Luca parla
di pianura), sottolineano il carattere di Gesù come un
nuovo Mosé e che, pertanto, le sue parole devono essere
intese come lo statuto che deve reggere le relazioni tra gli
esseri umani, vista la presenza del Regno divino.
L'ambientazione (Mt 5,1-2) presenta Gesù mentre rivolge
la parola ai discepoli che si avvicinano a Lui. A loro rivolge
principalmente i suoi insegnamenti, ma la menzione della folla
vuole significare che attraverso loro l'insegnamento del maestro
si rivolge a tutti. L'inizio di questo primo discorso di Gesù
viene narrato attraverso un "al vedere" seguito dal
verbo "dire" come avviene anche nel racconto dell'inizio
della predicazione di Giovanni. Il parallelismo tra Giovanni
e Gesù è segnalato costantemente nel primo Vangelo,
sebbene qui serva per sottolineare le differenze. La formula
citata serve, nel caso di Giovanni, per introdurre una denuncia
dei farisei e dei sadduccei, mentre in questo caso si tratta
di un annuncio in cui non compare alcuna parola di condanna.
Originariamente, le beatitudini bibliche (macarismi) si presentano
come una proposta di vita piena. Si alternano con quella della
formula più sacrale di "benedetto" e promettono
questa pienezza a coloro che assumono certi comportamenti sul
loro cammino (verbo ebraico al quale etimologicamente può
essere legato il termine "felice"). Si tratta allora
di una proposta capace di colmare la vita di allegria e felicità.
La comparazione con Luca pone inoltre in rilievo questo carattere.
In questo autore insieme alle beatitudini appaiono i guai corrispondenti,
assenti in Matteo. Le conseguenze negative saranno consegnate
solo in Mt 23 nella condanna agli scribi e ai farisei dopo un
continuo rifiuto alla proposta di Gesù.
Il testo, se consideriamo i suoi destinatari, può essere
articolato in due parti. I vv. 3-10 riguardano ogni essere umano,
mentre i versetti 10-11 concretizzano l'ultima beatitudine per
i discepoli a cui sembra riferirsi la seconda persona al plurale.
Nella prima parte è possibile stabilire una divisione
conforme al tempo in cui gli effetti della felicità si
realizzano. La maggior parte di loro avranno luogo in un futuro
non determinato, mentre nella prima e nell'ultima questi effetti
si possono già costatare nel presente.
Dentro il primo gruppo è possibile distinguere tra i
versetti 4-6 da un lato e i versetti 7-9 dall'altro. Nel primo
caso si parla di persone che sperimentano certe carenze nel
presente: gli umili, quelli che piangono, i pazienti. In secondo
luogo si afferma nelle stesse persone la presenza di atteggiamenti:
compassione, purezza di cuore e lavoro per la pace. I gruppi
menzionati sono dipendenti rispetto ai gruppi della prima e
dell'ultima beatitudine che seguono o precedono. Le carenze
consegnate primariamente sono esplicazione delle carenze dei
"poveri di spirito" e a quelle seguono gli atteggiamenti
richiesti per ottenere la giustizia, causa della persecuzione.
Ai poveri e ai perseguitati appartiene già il Regno di
Dio.
In questo modo il testo pone in intima relazione povertà
e persecuzione a causa della giustizia e, di conseguenza, l'associazione
della ricchezza con la politica di oppressione, attualizzando
cosi il messaggio di Sofonia della prima lettura. L'azione del
profeta deve essere collocata al tempo del regno dell'empio
Manasse. Il tributo all'impero Assiro porta all'adozione di
misure che danno come conseguenza un impoverimento del settore
contadino. Di fronte allo scontento che suscitano le sue misure
economiche, il re reprime duramente ogni opposizione, soprattutto
quelle originate nel circolo dei profeti.
In questo contesto il messaggio di Sofonia colloca la speranza
destinata ai poveri e alla realizzazione della giustizia. La
promessa non può essere legata ai poteri che opprimono
ma a un "popolo povero e umile"… a coloro che
"non commetteranno crimini".
Di fronte alla logica della felicità dei potenti, legata
all'abbondanza propria di una società di concentrazione
di beni in poche mani, Matteo con la stessa logica di Sofonia
vede l'attualizzazione del Regno di Dio nella condivisione dei
beni, in un economia di sussistenza. La "povertà
di spirito" deve essere intesa come progetto di condivisione
opposto al progetto di accumulo delle società imperiali
opulenti che causano la sofferenza e impediscono la realizzazione
della giustizia del Regno.
L'ultima beatitudine concretizza per la comunità cristiana
questa esperienza di ricerca della condivisione che produce
felicità anche in mezzo alle persecuzioni e alle difficoltà,
partecipando alla stessa lotta dei profeti.
La stessa logica proposta da Matteo, è quella che ricorda
Paolo alla comunità di Corinto, dove la forza di Dio
si concretizza nelle persone che non sono ritenute forti ne
sagge dall'opinione comune ma che sanno rendere concreta la
presenza di Cristo, forza e sapienza di Dio, perché "colui
che è orgoglioso sia orgoglioso nel Signore".
Per
la revisione di vita
Le
beatitudini non sono una teoria, un buon desiderio di Gesù,
ma una delle migliori descrizioni di ciò che Gesù
stesso fu e visse. Succede lo stesso con me? Mi descrivono le
beatitudini?
Per
l'incontro di Gruppo
-
Che fu quel "resto d'Israele", gli "anawin",
i poveri in spirito? Cosa significa essere "povero di spirito"?
- Nella comunità di Paolo si erano riuniti i poveri…come
stanno i poveri nella nostra comunità: presenti o assenti,
accolti o rifiutati, soggetti o oggetti?
Per
la preghiera dei fedeli
-
Perché non cessi mai di esistere nel mondo un "resto
d'Israele", persone umili e semplici che con fede in Dio
mantengono fermi i valori dell'amore e della speranza…
- Per tutte le comunità cristiane dove si riuniscono
e partecipano i più poveri, perché non siano mai
emarginati nella chiesa…
- Perché la chiesa si esamini specchiandosi continuamente
nelle beatitudini…
- Per coloro che si considerano "poveri di spirito"
pur essendo lontani dalla povertà e dai poveri, perché
il Signore dimostri che questo non fui il cammino che Egli seguì…
- Perché la nostra eucarestia domenicale sia sempre uno
spazio privilegiato di preghiera e di incontro comunitario…
- Perché il Vangelo delle Beatitudini ci renda veramente
"Beati" e diamo testimonianza che veramente il Vangelo
è una "Buona Notizia"…..
Orazione
comunitaria
Dio
Padre nostro che in Gesù hai portato al nostro mondo
nelle tenebre la buona notizia, il tuo annuncio di salvezza,
fa che la nostra vita si trasformi veramente per la gioia di
questa buona notizia, perché ci sentiamo "beati"
e diventiamo anche noi una beatitudine per il mondo. Per Cristo
nostro Signore.